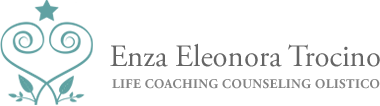Poesia, poesia/ Sembra che non ci sia…/Poi l’incontri per caso/ fra le mani di un bimbo perché/ lui cammina cantando/ Ride, gioca coi sassi/ Sogna che può volare/ E tutto questo è/ Poesia.
Cosi cantava, nel 1983, Riccardo Cocciante. E davvero la poesia è intorno a noi: permea la nostra vita, se sappiamo guardare.
Ma la poesia, naturalmente, è anche qualcosa di più specifico: una forma d’arte che io amo particolarmente, con cui talvolta mi esprimo. Spesso, nelle mie meditazioni o nei riti, propongo testi poetici: forse, non mi sono mai soffermata a spiegare perché. Lo faccio ora.
“Il valore pedagogico più rilevante della poesia risiede nella disponibilità dell’esperienza del poeta”, scriveva nel 1985 lo scrittore e saggista Daniele Giancane: come a dire che il primo, ineguagliabile merito della poesia è di mettere in comunicazione chi l’ha creata e chi la ascolta “da cuore a cuore”. La poesia tende ad azzerare i gradi di separazione, a farci sentire le esperienze e le emozioni dell’altro “dal di dentro” e quindi, inevitabilmente, a metterci in comunicazione più profonda con le nostre.
La prima funzione della Poesia è dunque rivelatrice: il linguaggio poetico apre una breccia, ci permette di fare un salto di livello, è un significante attraverso cui passano significati infiniti.
È interessante notare come il termine “poesia” venga dal verbo greco ποιέω (poiéo), che significa “fare” : lungi dall’essere qualcosa di astratto, futile o staccato dalla realtà, la poesia è quindi un agire. Un agire seminando bellezza. La poesia parla la lingua mai ovvia dello stupore: valorizza il chiaroscuro, segue la meraviglia e in questo modo genera apprendimenti inaspettati.
La poesia è un’opportunità per leggerci dentro, per non avere paura del nostro inconscio, per guardare in faccia le nostre zone buie e poter così veder emergere le stelle. Il suo linguaggio pieno di metafore ci permette di intuire l’ignoto attraverso ciò che ci è già noto: è un ponte verso l’infinito.
Potremmo pensare che la poesia produca parole. Ma, attenzione, ci mette in guardia lo psicanalista Umberto Galimberti, a non commettere errori di prospettiva; non è il pensiero a produrre linguaggio, se mai il contrario: “siamo in grado di pensare solo le parole che conosciamo”. I poeti, allora, ricombinando le parole in modo inedito, travalicandone il significato, spingendo la comprensione più in là, sono in grado di allargare la nostra immaginazione: ci aprono la mente e il cuore a concetti nuovi, ancora impensati, altrimenti inarrivabili. La poesia scardina la grammatica della razionalità, parla la lingua delle emozioni e, per farlo, frequenta la follia. Scrive Alda Merini, parlando di se stessa e della sua necessità di poetare: “Sono nata il ventuno a primavera/ ma non sapevo che nascere folle/ aprire le zolle/ potesse scatenar tempesta/ Così Proserpina lieve/ vede piovere sulle erbe/ sui grossi frumenti gentili/ e piange sempre la sera./ Forse è la sua preghiera”. Come ogni ricerca, infatti, la poesia ha a che fare con il divino, con la trasformazione e con la rinascita: per questo, non è mai sterile ma non è mai indolore. È la crepa da cui entra la luce, il passaggio aperto nella foresta, il Matto dei Tarocchi.
La poesia, che comunica attraverso la sua forma, rende chiaro che comunicare è molto più che scambiarsi informazioni, molto più che “arrivare da qualche parte”: l’importante è il viaggio. “Quando ti metterai in viaggio per Itaca/ devi augurarti che la strada sia lunga,/ fertile in avventure e in esperienze – scrive il poeta greco Konstantinos Kavafis – (…) senza aspettarti ricchezze da Itaca./ Itaca ti ha dato il bel viaggio/ senza di lei mai ti saresti messo/ in viaggio: che cos’altro ti aspetti?/ E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso/ Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso/ già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare”.
La poesia ci insegna che la perfezione non è avere tutto, ma avere tutto e solo ciò che serve, giacché mai in una poesia potranno esserci parole di troppo. La bellezza è misura, ricerca, mistero. Non tutto è subito chiaro, non tutto significa la stessa cosa per tutti.
“Io guardo ogni cosa come se fosse bella, e se non lo è, vuol dire che devo guardare meglio”, scrive Franco Arminio, non a caso uno dei miei poeti contemporanei prediletti: la sua poesia, capace di semplicità disarmante e di incredibile profondità, intrisa di realtà ma anche di leggerezza, mi colpisce dritta al cuore perché sento la sua ricerca particolarmente vicina alla mia. In una raccolta dal titolo geniale “L’infinito senza farci caso”, Arminio scrive anche così: “Prima di morire troverò/ quello che cerco/ E se non accade/ cercherò anche dopo,/ getterò i miei atomi allo sbaraglio/ nell’universo,/ ti cercherò/ dentro un albero,/ una tegola,/ una scarpa”. Perché, dice da un’altra parte: “Il mondo è fatto così. Se non lo allarghi si stringe”.
E ad allargarlo, come sempre, ci pensa l’Amore. La compassione. La capacità di riconoscere l’altro come un altro se stesso. Chandra Livia Candiani, un’altra delle mie preferite, rende l’idea con queste parole: “L’universo non ha un centro,/ ma per abbracciarsi si fa così:/ ci si avvicina lentamente/ eppure senza motivo apparente,/ poi allargando le braccia,/ si mostra il disarmo delle ali,/ e infine si svanisce,/insieme,/ nello spazio di carità/ tra te/ e l’altro”.
Come con ogni altra via per la conoscenza, non si tratta di “farsi piacere la poesia” ad ogni costo: ciascuno ha il proprio linguaggio e ogni cammino è sacro. La questione, se mai, è rimanere aperti e ricettivi, perché a volte, a risuonare con le nostre emozioni profonde, è lo strumento più inaspettato : “Venne la poesia a cercarmi – chiosa Paolo Neruda – Non so, non so da dove uscì, da quale inverno o da fiume. (…) Ed io, essere minimo, ebbro del grande vuoto costellato, a somiglianza, a immagine del mistero, mi sentii parte pura dell’abisso, rotolai con le stelle, si sciolse il mio cuore nel vento”.
Ecco: auguro a ciascuno di noi che si sciolga il nostro cuore nel vento.